Nel mio ultimo post ho nominato l’empatia come una delle capacità che alberga nei bravi psicologi. Per capire meglio di cosa si tratta guardate e ascoltate attentamente questo simpatico cartone animato! A presto con un altro argomento.
Pregiudizio 5: Nessuno può capire il mio dolore!
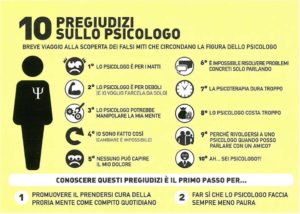
Per la rassegna “sfatiamo vecchi pregiudizi” siamo arrivati ad uno che mi preme davvero molto: “nessuno può capire il mio dolore!”. Ci tengo molto a discutere questa credenza perché non farlo significherebbe dire a tante persone che soffrono o che hanno un problema che non si può far nulla per loro, che non è possibile aiutarle e questo oltre che falso sarebbe dannoso.
Sarebbe utile sapere da voi pubblico quali sono i motivi che portano ad una simile credenza. Forse non si è trovato qualcuno veramente capace di ascoltare o aiutare o forse si crede di avere un problema troppo grande o irrisolvibile. Io vi posso raccontare un episodio che mi è capitato durante una serata pubblica in cui parlavo di ansia e panico. Una persona tra il pubblico mi ha informato di essere affetto da attacchi di panico da molto tempo e mi ha chiesto se io avessi mai sofferto di attacchi di panico. Prima di rispondere ho chiesto come mail volesse avere questa informazione da me e la sua risposta è stata: “Perché se lei non ha sofferto di attacchi di panico, non può capire davvero come mi sento e non può sapere come aiutarmi!”
E’ stata sicuramente un’affermazione forte ed ho ritenuto fondamentale andare a fondo della questione. In prima battuta ho replicato così: “Quindi secondo il suo ragionamento io dovrei aver sofferto di tutti i disturbi mentali conosciuti per poter comprendere i miei pazienti ed esercitare bene la mia professione?”. Che ciò sta a dire che solo chi ha avuto esperienza diretta di un certo problema sa come risolverlo. Poi ho aggiunto: “Se questo è il suo pensiero allora dovrebbe chiedere ad un medico se ha sofferto di tutte le malattie presenti al mondo, dall’influenza al tumore, perché solo così saprebbe come curare le persone”. Ma è possibile una cosa del genere? Facciamo ai professionisti (non psicologi) a cui ci rivolgiamo questo tipo di domande prima di affidarci a loro? Ovviamente no! Di solito quando si decide di rivolgersi ad un professionista si cercano informazioni sulla sua formazione, sulla sua esperienza lavorativa in un certo campo e sul parere dei suoi assistiti.
Perché invece per la categoria psicologi questo non basta? Perché le persone si aspettano qualcosa di più? Credo che la questione stia tutta nella fiducia. Probabilmente ci sono ancora persone che hanno poca fiducia nella professione dello psicologo per timore o per scarsa informazione. In uno dei primi articoli ho spiegato quanto ancora ci sia da fare da parte della categoria per farsi conoscere e apprezzare come una reale possibilità di aiuto o di miglioramento delle condizioni di vita. Però credo serva anche un piccolo atto di fiducia da parte del pubblico, un provare a mettere in discussione le proprie idee e mettersi in gioco, esattamente come si farebbe se ci si dovesse rivolgere ad un nuovo dentista o idraulico o avvocato. In questi casi di solito ti informi se è bravo, da quanto lavora, quanto chiede, se i tuoi amici si sono trovati bene con lui e poi lo chiami e fissi un appuntamento. E se poi non si rivelasse all’altezza delle aspettative ne chiameresti un altro. Perché non fare la stessa cosa anche quando si deve scegliere uno psicologo? Di solito le persone che mi hanno contattato hanno fatto proprio così. Per concludere il discorso sulla fiducia vi racconto come si è conclusa la discussione con la persona di cui sopra. Alla fine ho risposto alla sua domanda e ho raccontato a tutto il pubblico in sala che effettivamente per un certo periodo della mia vita ho sofferto di attacchi di panico e che quindi potevo esattamente comprendere come si sentiva. D’altronde noi psicologi siamo esseri umani e pertanto non siamo esenti da momenti di difficoltà. Quando è successo mi sono rivolta anch’io ad un collega per farmi aiutare. Ho spiegato quindi al mio interlocutore che, sebbene io possa comprendere molto bene come si sentono le persone ansiose, questo fatto non mi rende necessariamente migliore di tanti altri miei colleghi che l’ansia non l’hanno mai avuta, perché le cose che contano nel nostro lavoro sono la preparazione, l’esperienza, l’empatia, la capacità di ascolto e tante tante altre cose che adesso non mi dilungo ad elencare. (Siccome l’empatia credo sia una capacità fondamentale per gli psicologi, sabato scriverò un approfondimento su questo tema.)
Ora vi saluto con un paio di domande: “Secondo voi il mio interlocutore si è sentito rassicurato dal fatto che io avessi sofferto di attacchi di panico come lui e quindi potessi capirlo? Secondo voi ha preso poi contatti con me per farsi aiutare?” Vediamo chi ha voglia di rispondere a questi miei quesiti. Nel frattempo vi auguro buona serata e ci sentiamo presto su questa “rete”.
Serata divulgativa: “Dalla RABBIA alla VIOLENZA”

All’interno della rassegna di incontri “I giovedì della Psicologia” che si terranno presso il Centro Clinico di Verona, il dr. Andrea Pasetto, la dr.ssa Francesca Gamba e la dr.ssa Michela Pinton condurranno la serata di Giovedì 24 Gennaio 2019 dal titolo “Dalla RABBIA alla VIOLENZA”.
Prossimamente vi daremo maggiori dettagli sugli argomenti della serata.
PREGIUDIZIO 4: “Io sono fatto così, è impossibile cambiare!”
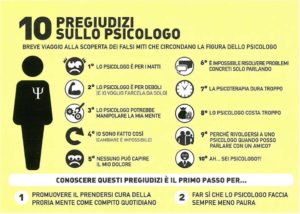
Continuiamo a sfatare vecchi pregiudizi. E’ vero che non si cambia? Beh, questa idea mi sembra si possa confutare facilmente. Tutti noi cambiamo continuamente: cambiamo idea, cambiamo ciò che sentiamo, cambiamo comportamento, cambiamo amici e partner, cambiamo progetti di vita e stili di vita. E meno male che è così, aggiungo. C’è ancora qualcuno convinto del contrario? Se sì, parliamone.
Cominciamo col definire che cos’è il cambiamento. Il cambiamento è la normale risposta con cui un sistema vivente supera gli ostacoli che un ambiente pone al raggiungimento dei propri scopi. Cambiare quindi ci permette di adattarci meglio al contesto in cui viviamo e di raggiungere i nostri scopi. Il cambiamento quindi può essere dovuto a fattori esterni o ad una motivazione interna. Facciamo degli esempi. Si può decidere di smettere di fumare, quindi cambiare un comportamento, un’abitudine, per migliorare il proprio stato di salute. Si può decidere di chiudere una relazione sentimentale perché non risponde più ai nostri bisogni, desideri, aspettative. Si può cambiare ideologia politica se ci si rende conto che provoca danni per sé e per gli altri come la storia ci insegna. Possiamo infine cambiare tutto di noi se ci troviamo ad affrontare eventi traumatici o catastrofici come la guerra o una calamità naturale. Ecco perché prima commentavo che è una fortuna che si possa cambiare. Se così non fosse probabilmente saremmo estinti.
Acclarato quindi che si può cambiare ed è un bene per tutti noi, è possibile che chi è convinto del contrario in realtà abbia qualche difficoltà a cambiare: in psicologia si parla di resistenza al cambiamento. Cerchiamo di capirne i motivi. I motivi posso essere tanti e diversi:
- Scarsa consapevolezza di sé per cui una persona non si rende conto che potrebbe cambiare oppure che già sta cambiando ma percepisce solo confusione e senso di non appartenenza alla vita che conduce;
- Paura del cambiamento e difficoltà ad assumersi dei rischi per proteggere la propria identità e perché spesso cambiare significa buttarsi in qualcosa di nuovo e ignoto;
- Sfiducia e pessimismo verso sé stessi e le proprie capacità rispetto alla possibilità di cambiare;
- Senso di colpa per cui non ci si ritiene di avere il diritto di cambiare;
- Attribuzione esterna di tutto ciò che accade per cui si è convinti che siano gli altri o l’ambiente a dover cambiare.
Tutti questi motivi ci fanno capire che non tutti sono ugualmente disposti al cambiamento e non tutti riescono a mettersi in gioco. Le difficoltà di queste persone vanno comprese e accolte, ognuno con i suoi tempi. Tuttavia spero, con questo breve testo, che il cambiamento possa ora essere visto come qualcosa di possibili e di positivo. Ci risentiamo presto per confutare un altro mito.
Perchè i ragazzi si sballano?

Articolo a cura della Dr.ssa Federica Turri
L’adolescenza è un periodo evolutivo molto delicato, durante il quale i ragazzi affrontano profondi cambiamenti a livello fisico e psicologico. Questa è una fase di curiosità e scoperta: i ragazzi cercano di conoscere se stessi testando i propri limiti, anche attraverso nuove esperienze. Talvolta però sottovalutano i rischi e si espongono a comportamenti inconsueti, non sempre sani, spesso per non sentirsi esclusi dagli amici. Il gruppo dei pari, infatti, diventa a questa età il principale punto di riferimento e l’ansia del giudizio sociale o la paura di sentirsi diversi e inadeguati possono spingerli a condotte particolari.
Ecco che allora può nascere il desiderio di provare sostanze come la cannabis o l’alcol. Spesso ciò può accadere anche come risposta al bisogno di ribellarsi alle regole genitoriali o al tentativo di trovare un modo nuovo per svagarsi. Quando iniziano i primi contatti con queste esperienze, di solito l’adolescente non è consapevole dei rischi a cui si espone, quindi generalmente non chiede aiuto e tiene la famiglia all’oscuro di quanto gli sta accadendo. È importante comunque sapere che un primo contatto con le sostanze non rappresenta necessariamente l’inizio di un percorso di tossicodipendenza. Anzi, nella maggioranza dei casi si tratta di comportamenti a scopo ricreativo che rimangono ad un livello contenuto e che poi tendono a risolversi spontaneamente nel tempo, con l’acquisizione di abitudini più sane.
Sono invece a rischio quei ragazzi che continuano ad utilizzare queste sostanze o altre più pesanti perché si sono rivelate funzionali alla gestione di stati emotivi interni particolarmente dolorosi: giovani molto timidi, in fase depressiva, alle prese con importanti problematiche familiari o personali, possono trovare nelle sostanze un iniziale aiuto per attenuare questi malesseri, senza rendersi conto del pericolo della dipendenza che si può instaurare. In questi casi è possibile che le droghe diventino “compagne di strada”, “stampelle” a cui il giovane si appoggia non trovando in se stesso o nel contesto intorno a sé risorse alternative per affrontare il momento di difficoltà. Quindi quando il giovane non è più in grado di fermare l’abuso, significa che si è instaurata una dipendenza, che non è un vizio facilmente risolvibile con la buona volontà, ma una vera e propria malattia che richiede terapie mirate.
3 possibili conseguenze dell’uso delle nuove tecnologie sui nativi digitali.
Riflessioni sulla puntata del 15/10/2018 di Presa Diretta: Iperconnessi!
Viviamo nell’era digitale e siamo costantemente connessi alla rete attraverso l’uso dei devices: smartphone, tablet e pc. E’ un fenomeno generalizzato e inarrestabile oramai, ma ci siamo mai fermati a riflettere seriamente sull’impatto che ha questo nuovo stile di vita, in particolare sui giovani d’oggi, quelli che vengono definiti i nativi digitali?
Sabato scorso mi sono imbattuta in una interessante inchiesta di Presa Diretta sulle conseguenze dell’uso delle nuove tecnologie. Consiglio a tutti di vedere l’intera puntata per capire le conseguenze di questo fenomeno sul funzionamento del nostro cervello. Tuttavia ho deciso di proporvi solo un breve passaggio dell’intero video per riflettere con voi su cosa sta accadendo ai giovani di oggi.
Nell’intervista parlano un’insegnante di un liceo e, a seguire, una scrittrice che ha studiato il fenomeno nelle nuove generazioni. Se penso ai giovani con cui mi rapporto nell’ambito della mia professione, mio malgrado devo concordare con quanto raccontano. Quando lavoro a scuola con questa fascia d’età mi scontro con le stesse difficoltà: problemi di lettura, scrittura, comprensione del testo e non sto parlando di ragazzi con disturbi dell’apprendimento, ma di ragazzi normali.
Quando chiedo agli alunni di leggere un testo, la prima lamentela riguarda la lunghezza, anche se il testo non supera una facciata. Poi quando leggono, la lettura spesso risulta lenta, stentata, piena di errori. Già da questo si può capire che non sono abituati a leggere. Se chiedo quale sia la lettura preferita di solito la risposta è: nessuna. Non leggono. Ora non voglio sostenere che quando ero ragazza io si leggessero carrettate di libri, anzi. Credo che in ogni epoca siano rari i ragazzi che si appassionano alla lettura. Quando ero giovane si preferiva uscire a giocare con gli amici, oggi i ragazzi preferiscono chattare e navigare nella rete. Tuttavia qualcosa all’epoca mia si leggeva, fossero anche solo fumetti e libri per ragazzi e poi c’era la scuola che ti obbligava a leggere dei libri. La didattica scolastica contemporanea è cambiata e solo in qualche caso ho incontrato insegnanti che chiedono ancora la lettura di libri per intero. Molto più spesso gli alunni leggono solo brani o stralci di un testo. La didattica scolastica è diventata smart?
La scrittura: concordo sul fatto che ormai pochissimi scrivono usando il corsivo e la calligrafia, detta anche bella grafia, è rara. La punteggiatura non esiste e spesso vengono usati simboli o parole contratte nello stile dei messaggi, come ad esempio xkè, xò, cmq…. Non parlo neanche degli errori di ortografia. Leggere un testo scritto in questo modo diventa un’impresa estenuante per quanto tempo ci devi mettere a decifrarlo e a comprenderlo. Ogniqualvolta ho fatto notare ad un ragazzo la mia difficoltà nel leggere e comprendere un suo testo, sono stata guardata come un aliena e come se fosse colpa mia che non capivo. E’ come se questi ragazzi dessero per scontato che l’interlocutore li capisca e che quindi non sia necessario porsi il problema e impegnarsi per farsi capire.
La comprensione del testo credo sia la parte più deficitaria, tra tutte. Acquisire delle informazioni tramite ascolto o lettura, elaborarle e riuscire poi a riprodurle in un discorso di senso compiuto per molti sembra un compito estremamente difficile. Se l’attenzione dura ormai lo spazio di meno di un minuto è logico che le informazioni saranno scarse e frammentate ed è altrettanto logico che la riproduzione di quanto appreso si trasformi o nella sintesi, della sintesi, della sintesi di ciò che era in origine oppure in qualcosa di inventato perché integrato con altre informazioni presenti nella testa dei ragazzi. Il punto è che nessuno di questi esiti è buono. Non si può ridurre tutto ad un twitter o ad una fake news.
E vi siete chiesti cosa resta di queste informazioni in memoria? E sapete a cosa serve la memoria? Di questo ulteriore passaggio potrebbe essere utile riparlarne in maniera più approfondita. Per ora vi lascio riflettere sui 3 aspetti appena descritti, che mi sembra già molto. Non voglio lasciarvi con un’aria di pessimismo su questo argomento, perciò vi informo che ci sono tantissime ricerche in atto e che moltissimi esperti, tra medici, neuroscienziati, filosofi, psicologi e anche altri professionisti, si stanno adoperando per comprendere questo recente fenomeno e trovare delle soluzioni. Nel frattempo anche noi nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa per limitare i danni: possiamo informarci sulle conseguenze dell’uso dei dispositivi tecnologici, possiamo cercare di ridurre per quanto possiamo il tempo di esposizione ad essi, possiamo dedicarci ad attività alternative che ci consentano tempi più lenti e rilassati e che sviluppino capacità diverse del nostro cervello.
Convegno: I giovani e i disagi della sessualità.



Sabato scorso ho partecipato al convegno “I giovani e i disagi della sessualità”. Le relazioni sono state tutte molto interessanti e ricche di spunti per il futuro. Prossimamente vi parlerò degli argomenti che mi hanno colpito di più. Buon inizio settimana a tutti!
Pregiudizio 3: lo psicologo potrebbe manipolare la mia mente!
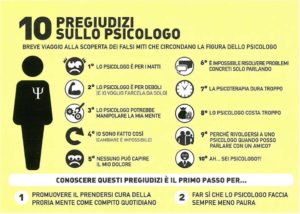
In questo articolo vi svelerò i segreti del mestiere. Scopriamo insieme se e come uno psicologo può manipolare la mente delle persone.
In realtà questo pregiudizio mi sembra alquanto superato. E’ passato molto tempo da quando ho sentito una frase del genere. Nei pochi casi in cui mi è stata rivolta, magari anche solo come battuta, ho sempre posto questa domanda: “Secondo te come posso fare a manipolare la mente delle persone?” Di solito le persone danno risposte molto vaghe del tipo “Eh… che ne so io come fai? Tu sai i trucchi del tuo mestiere!” oppure “Magari mi ipnotizzi e mi fai fare quello che vuoi!”
Bene, sveliamo allora i trucchi del mestiere, sono convinta che informare, spiegare, comunicare il più possibile sulla professione dello psicologo sia molto importante per superare dubbi e timori.
Che modi può avere uno psicologo per manipolare la mente delle persone?
- Non può usare dei farmaci perché non è un medico e quindi non è abilitato a prescriverli e somministrarli.
- Per la mia specifica formazione non utilizzo l’ipnosi come tecnica terapeutica, ma so che serve una formazione specifica per poterla utilizzare e che non tutti gli psicoterapeuti la praticano. Alcune persone credono consista in una perdita di coscienza, dove il terapeuta può controllare la mente del paziente ma non è così. Si tratta di un’esperienza di trance in cui non può venire modificata la personalità, la volontà e i principi morali della persona che si sottopone a questa pratica.
- La parola, il colloquio, questo sì è il mezzo utilizzato dagli psicologi e psicoterapeuti per svolgere il proprio lavoro. Il colloquio in psicologia è uno strumento di conoscenza che utilizza la comunicazione allo scopo di raccogliere informazioni con fini di ricerca, di diagnosi o di presa in carico per un determinato trattamento. Il colloquio tra uno psicologo e colui che lo consulta può avvenire solo se c’è una motivazione e un interesse autentico da parte di entrambi. Se una persona ha paura di essere manipolata mentalmente da uno psicologo non credo che chieda un colloquio. Chi invece ha provato questa esperienza penso possa rivelare di cosa si tratta ed essere più convincente di me nel spiegarlo, visto che io sono di parte.
Insomma credo davvero che si tratti solo di suggestioni, fantasie o chiacchiere poco attinenti con la realtà. Le persone che si rivolgono agli psicologi e si sottopongono a delle sedute o a percorsi di psicoterapia sono in continuo aumento ma di solito per motivi di privacy non raccontano la loro esperienza. Io però le inviterei tutte a descrivere come si è svolto il loro colloquio, senza entrare nello specifico dei motivi che le hanno portate a chiedere un consulto. Sono convinta che i loro racconti sarebbero molto più chiarificatori e istruttivi delle mie parole. Perché quindi non provarci? Potete usare anche questo spazio per raccontarvi, ne sarei felice. Buona giornata a tutti.
Pregiudizio 2: lo psicologo è per i deboli e io posso farcela da solo!
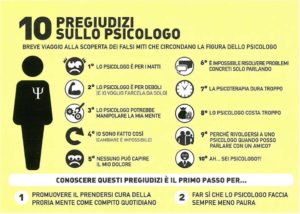
Ma funziona davvero così? Davvero riusciamo a cavarcela da soli quando abbiamo un problema psicologico? In questo articolo proverò a sviscerare il secondo pregiudizio in elenco analizzando pro e contro del tentativo di risolvere un problema di questa natura da soli.
E’ sicuramente vero che ognuno di noi è cresciuto con l’insegnamento che nella vita bisogna imparare a risolvere i problemi da soli, con le proprie capacità, con i propri mezzi. Ma è altrettanto vero che dove non siamo in grado di far da soli possiamo chiedere aiuto a chi ci sta vicino o a chi è più esperto di noi. Facciamo degli esempi: se al lavoro il tuo capo ti dice che devi imparare ad usare un nuovo programma del pc, tu magari provi a fare l’autodidatta consultando il manuale ma se alla fine non ci riesci, magari chiedi aiuto ad un tuo collega oppure segui un corso per imparare ad usare quel nuovo sistema; se per caso ti senti poco bene puoi provare a curarti da solo dando fondo a tutte le medicine che hai in casa o chiedendo alla mamma qualche rimedio magico ma se il malessere continua poi vai dal medico. E per aggiungere un dettaglio…… “Di solito non aspetti mesi o anni per andare dal medico, vero?” Quindi nella realtà dei fatti noi cerchiamo di risolvere i nostri problemi autonomamente fin dove riusciamo, oltre, giustamente, chiediamo aiuto.
Secondo voi succede così anche quando il problema è di natura psicologica? Voi come vi comportate in questi casi? Posso dirvi che per la mia esperienza, le cose non vanno allo stesso modo per diversi motivi.
- A volte le persone non si rendono conto di aver a che fare con un problema di natura psicologica, ma credono si tratti magari di una malattia (come ad esempio una persona ansiosa che pensa di avere un attacco cardiaco) o di un problema pratico (come decidere se lasciare il vecchio lavoro per uno nuovo o restare).
- A volte le persone non sanno riconoscere in tempo segni e sintomi dell’esordio di un problema psicologico e se ne rendono conto solo quando il disturbo è diventato grave e molto invalidante per la loro vita.
- A volte le persone credono che ci si rivolge allo psicologo solo per curare patologie gravi e non sanno che invece lo psicologo può semplicemente aiutare per piccoli problemi quotidiani o promuovere il benessere personale. Per capire meglio potete rileggere l’articolo sul pregiudizio n.1.
Ma l’argomentazione più bella di tutte che di solito sento dire è: “il tempo risolve ogni cosa!” Non ho mai sentito una c…ata più grande di questa. Chi ci crede veramente dovrebbe spiegarmi come fa il tempo a risolvere i problemi e dirmi perché con me non l’ha mai fatto??? Gli sto forse antipatica?! Sempre nella mia piccola esperienza quello che vedo è che più passa il tempo e più le cose si complicano e spero di dimostrarvi perché succede questo. Quando le persone hanno un problema psicologico di solito tentano delle soluzioni fai da te oppure cercano di accantonare il problema nella speranza che magicamente col tempo sparisca da solo. Che sia chiaro, non giudico assolutamente le scelte delle persone anzi cerco di capirle, tanto è vero che indago a fondo tutto ciò che hanno tentato di fare per risolvere il loro problema. Credo che a molti manchino le conoscenze sufficienti per affrontare un problema di natura psicologica e che non si rendano conto che le soluzioni che adottano peggiorino il problema invece che risolverlo. Vi ricordate l’assunto base della psicoterapia cognitivo comportamentale? I problemi emotivi e comportamentali sono in gran parte il prodotto di credenze disfunzionali che si mantengono nel tempo, nonostante la sofferenza che provocano al paziente. In sostanza un certo modo di pensare e di agire può influire negativamente sullo stato emotivo ma nonostante questo non si è capaci di cambiarlo. Il passare del tempo non aiuta perché pensieri ed azioni restano le stesse. Col tempo aumenta solo la sofferenza perché si resta impigliati in un circolo vizioso da cui non si trova modo di uscire.
Faccio un esempio per chiarire meglio questo concetto. Una persona in un momento di stress potrebbe percepire un po’ di tachicardia. Se la persona pensa di avere un infarto, si preoccuperà ancora di più e i sintomi peggioreranno. Se dopo i dovuti controlli medici, tutti negativi, continua a credere che ogni volta che il suo cuore accelera potrebbe avere un infarto, col tempo starà sempre peggio perché la sua preoccupazione non cambierà. Se poi la stessa persona decide di non fare più il suo sport preferito, di non impegnarsi in attività troppo faticose o addirittura di non uscire più di casa per paura di avere un infarto, il suo problema peggiorerà sempre di più.
Con queste mie parole spero quindi che riconsidererete la funzione dello psicologo, che può essere di aiuto anche per piccoli problemi, per migliorare la nostra vita o anche solo per capire come funziona la nostra mente. Vi lascio con questo spunto di riflessione e ci risentiamo per parlare di un altro pregiudizio.
Similitudini e differenze tra la TCC per adulti e per bambini/adolscenti.

In un precedente articolo ho spiegato a grandi linee in cosa consiste la psicoterapia cognitivo comportamentale (TCC). Oggi vorrei entrare nello specifico dell’applicazione di questa terapia nella fascia d’età dello sviluppo, da 0 a 18 anni, delineando similitudini e differenze.
Vi ricordate quando ho parlato delle difficoltà di riconoscere un problema psicologico in un bambino/adolescente e come fare per superarle? Se dopo attenta osservazione siete giunti alla conclusione che vostro figlio o nipote o allievo sta manifestando i segni di un problema di natura psicologica, i passaggi da mettere in atto sono quelli elencati nell’articolo “Che differenza c’è tra uno psicologo per gli adulti e uno per bambini/adolescenti”. Si tratta quindi i fissare un primo colloquio con uno psicologo/psicoterapeuta, di sottoporre il minore ad una valutazione diagnostica, esattamente come farebbe un medico se si trattasse di un problema organico e di condividere col professionista l’esito della valutazione. Nell’incontro di restituzione lo psicologo/psicoterapeuta non solo formula una diagnosi, cioè spiega se si è in presenza di un disturbo o di un problema transitorio e quale, ma indica anche il possibile percorso da seguire per risolvere il problema. A questo punto quindi si entra nella fase di terapia vera e propria. La TCC per l’età evolutiva presenta similitudini e differenze rispetto alla TCC per gli adulti. Vediamo quali.
Similitudini:
- Gli assunti della psicoterapia cognitivo comportamentale per l’infanzia/adolescenza sono gli stessi che per gli adulti: pensieri, emozioni e comportamenti sono connessi tra loro in modo complesso e i problemi emotivi e comportamentali sono in gran parte il prodotto di credenze disfunzionali che si mantengono nel tempo, nonostante la sofferenza che provocano.
- Gli obiettivi della psicoterapia cognitivo comportamentale sono gli stessi: individuare la presenza di credenze e schemi di pensiero disfunzionali e successivamente aiutare il paziente a modificarli o integrarli con altri più funzionali per ottenere una remissione dei sintomi e promuovere il suo benessere personale.
- Le tecniche terapeutiche sono le stesse: si aiuta il paziente ad apprendere nuove modalità di risposta alle situazioni che si trova a vivere (terapia comportamentale) e a correggere o integrare i propri pensieri con altri più realistici e funzionali al suo benessere (terapia cognitiva).
Ma se assunti, obiettivi e tecniche sono gli stessi allora cosa c’è di diverso?
Differenze:
- La definizione dei disturbi psichici in età evolutiva è decisamente più complessa che per l’età adulta a causa dell’influenza di innumerevoli Infatti oltre ai fattori come le caratteristiche dell’individuo (caratteristiche biologiche, funzioni metacognitive, temperamento), gli aspetti sociali e culturali, di cui si tiene conto per l’età adulta, vi sono altri fattori da considerare come le trasformazioni maturative (organizzazione comportamentale, emotiva e cognitiva che non sono ancora definite e stabilizzate) e le caratteristiche familiari (relazione tra i genitori, relazione di attaccamento tra bambino e genitori, caratteristiche delle famiglie d’origine).
- Questa multifattorialità fa sì che un intervento settoriale come può essere la TCC individuale risulti poco efficace soprattutto a lungo termine. La presenza di più fattori favorisce invece lo sviluppo di modelli di trattamento di tipo multidimensionale quando sono rivolti all’età dello sviluppo. In questi trattamenti si cerca di integrare vari approcci terapeutici che si sono dimostrati efficaci e di promuovere un trattamento estensivo e periodicamente monitorato su più fronti, ovvero sul bambino/adolescente, sulla famiglia e sui contesti di vita più significativi per il minore come la scuola. L’intervento terapeutico multimodale, mirato non solo sul bambino/ragazzo ma anche sui genitori e se possibile su altri contesti (famigliare e/o scolastico) è quello che dà maggiori risultati in termini di riduzione dei sintomi.
- Un percorso terapeutico per un bambino/adolescente può essere condotto solo da uno psicoterapeuta specializzato, meglio ancora se esperto nel trattamento di questa fascia d’età. In alcuni casi può essere necessario anche combinare la psicoterapia con la terapia farmacologica, che però deve essere seguita da un neuropsichiatra infantile o psichiatra. Della farmacoterapia nell’età dello sviluppo scriverò in modo più approfondito più avanti.
Come sempre se avete domande o riflessioni da fare, postate pure. Nel frattempo auguro a tutti buona giornata.
