Salve a tutti,
ecco la seconda parte dell’intervista alla radio della dr.ssa Michela Pinton sul tema “Ansia e Psicoterapia”.
Buon ascolto e restate connessi!!!
Dr.ssa Michela Pinton

Salve a tutti,
ecco la seconda parte dell’intervista alla radio della dr.ssa Michela Pinton sul tema “Ansia e Psicoterapia”.
Buon ascolto e restate connessi!!!
Dr.ssa Michela Pinton
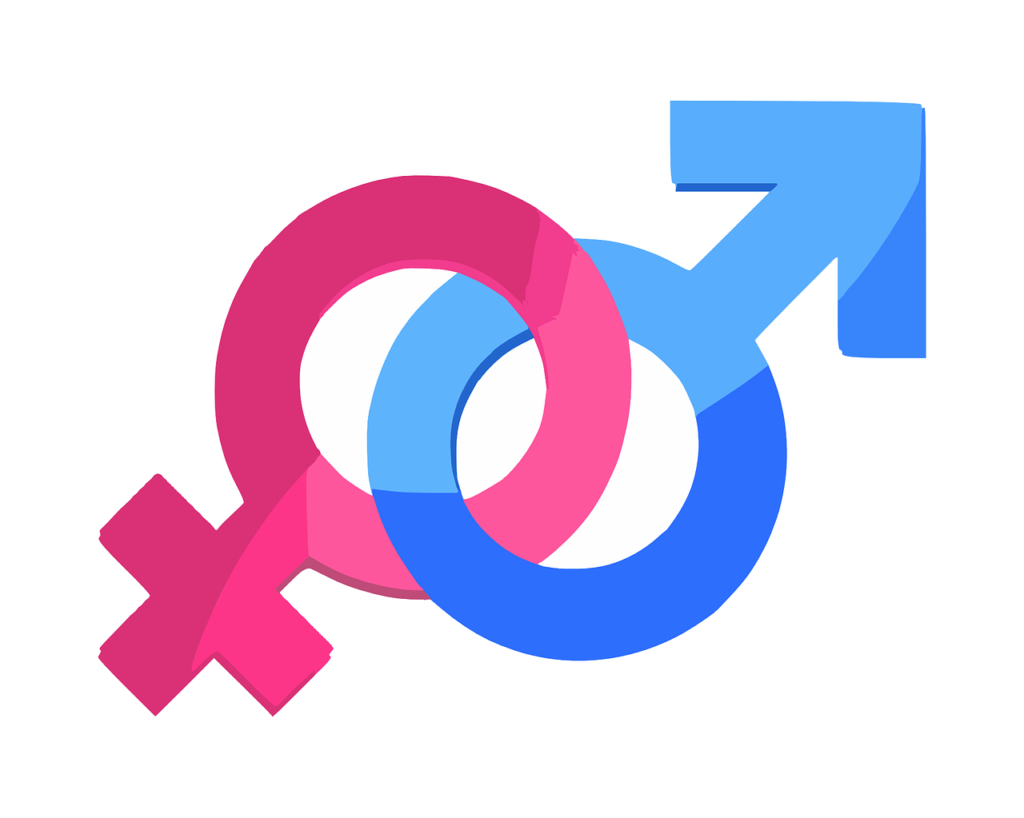
Continuando la nostra esplorazione sul tema adolescenti e sessualità, oggi vi parlerò della dipendenza dal sesso, di quali possono essere i fattori di rischio e di quali possono essere le conseguenze.
Dalle interviste di adolescenti che manifestano una dipendenza dal sesso, che può consistere in un accesso smodato a materiale pornografico, masturbazione frequente e protratta a lungo nel tempo o ricerca continua di rapporti sessuali “fast food”, tutte attività che finiscono con l’inficiare diversi ambiti della vita dei ragazzi (studio, famiglia, relazioni sociali, interessi….), si evince che molto spesso il sesso è usato come una sorta di confort zone in cui potere rifugiarsi per sfuggire ad un malessere emotivo interiore. Questi ragazzi infatti raccontano di provare una sorta di vuoto interiore o di dolore che però non riescono a nominare e condividere. Spesso questi stati emotivi angosciosi sono collegati a crisi d’identità, senso di inadeguatezza, senso di indegnità e disvalore, che possono emergere ed essere elaborati solo grazie all’aiuto di professionisti. Ma se i ragazzi si sentono soli in tutto questo, pur di uscire dallo stato di sofferenza, cercano il sesso ossessivamente perché la sofferenza in qualche modo ingloba tutto lo spazio della loro vita, ne rovina la qualità e li lascia senza speranza. Il sesso serve a placare almeno temporaneamente questo dolore.
Purtroppo questa soluzione ha dei risvolti ancora più negativi:
Per i ragazzi adolescenti non è facile rendersi conto di tutti questi rischi e conseguenze negative. Per questo motivo servono persone capaci di star loro vicino, di comprenderli, di ascoltarli senza giudizi e soprattutto di aiutarli ad entrare in contatto con i loro vissuti interni, per riconoscerli e condividerli. Inutile ripetere che noi psicologi siamo a disposizione per tutto questo, ma c’è ancora tanto lavoro da fare perché gli adolescenti sentano di avere questa possibilità. Work in progress!!!

In questo articolo vi darò qualche dato circa la fruizione in internet di argomenti che riguardano la sessualità da parte degli adolescenti e cercheremo di capire insieme cosa li spinge al cybersex (dipendenza da sesso virtuale) o a praticare il sexting (scambio di testi, immagini e video con contenuti sessuali espliciti con altri).
E’ sotto gli occhi di tutti ormai che gli adolescenti di oggi sono costantemente connessi a internet. Lo strumento che maggiormente usano per questo è lo smathphone perché permette loro di connettersi in qualunque momento, in qualunque luogo, in maniera del tutto autonoma e con minor controllo esterno. Tra tutti i contenuti disponibili nella rete, quelli sessuali costituiscono una buona fetta. Ricerche internazionali parlano di fruizione di contenuti sessuali da parte di bambini/ragazzi tra i 9 e i 17 anni in costante aumento. Sembra un fenomeno inarrestabile soprattutto tra i maschi. Il 50% dei casi accede a contenuti pornografici, i maschi in percentuale doppia rispetto alle femmine. L’età in cui di solito entrano in contatto con questi contenuti è tra i 10 e i 13 anni. Insomma il consumo di pornografia sembra essersi esteso e generalizzato da quando esiste il web.
Quali sono i motivi per cui gli adolescenti accedono a contenuti sessuali on line?
Una pratica molto in voga tra gli adolescenti è il sexting. Si scambiano contenuti sessuali personali per due motivi: per esplorare la sessualità, fare nuove esperienze o come forma di corteggiamento e dimostrazione di affetto. Il sexting di solito sottende un patto di reciprocità e fedeltà ma i ragazzi non sembrano in grado di prevedere i rischi di questa pratica. Per esempio non considerano il fatto che alla loro età, emozioni, sentimenti, relazioni possono cambiare velocemente e, con la leggerezza che li contraddistingue, il patto può rompersi facilmente. Le conseguenze sono spesso negative perché quei contenuti scambiati possono diventare un’arma di ricatto e possono essere divulgati nella rete. Gli esiti di simili comportamenti possono essere devastanti per la reputazione di una persona ed avere un impatto psicologico pesante. Fortunatamente esiti di questo tipo non sono molto diffusi.
Tirando le somme quali sono gli aspetti positivi e i rischi della fruizione dei contenuti sessuali dei ragazzi attraverso internet? Di positivo c’è che in fondo i nativi digitali non sono poi così diversi dagli adolescenti di qualche anno fa. Ciò che li muove è la curiosità, condividono ciò che sanno con i loro pari come accadeva un tempo e nella maggioranza dei casi il sesso virtuale è solo una componente aggiuntiva alle relazioni sociali che hanno nella vita reale. Di rischioso c’è che questi ragazzi non trovano ancora qualcuno di competente che sia in grado di comunicare con loro su questo argomento e di fornirgli le giuste competenze non solo in campo sessuale ma anche in campo affettivo, emotivo, relazionale. E poi il cybersex e il sexting, se non vengono praticati nel modo giusto, possono diventare effettivamente un problema per qualcuno di questi ragazzi. Voi cosa ne pensate? Che siate, genitori, insegnanti o altri di riferimento per ragazzi adolescenti, riuscite a parlare con loro di sesso? Quando ne parlate, quanto, come e di quali argomenti? Forse condividere le reciproche esperienze potrebbe essere di aiuto a chi ancora non è riuscito ad affrontare questo tema spinoso.

Nell’ambito del Convegno “I giovani e i disagi della sessualità” di qualche mese fa, un medico di base ha elencato le difficoltà che incontra quotidianamente nel tentare di occuparsi della fascia di età adolescenziale e mi sono resa conto che sono circa le stesse difficoltà che incontro io come psicoterapeuta.
Nel mio post precedente ho elencato i motivi per cui difficilmente un adolescente accede ai servizi a lui dedicati. Oggi proverò a dare qualche informazione e qualche spunto di riflessione nel tentativo di abbattere qualcuno di quegli ostacoli di cui sopra.
Mi rivolgo proprio a te ragazzo o ragazza, nella speranza che riuscirai a leggermi:
Chiudo questo post lasciandoti riflettere su queste ultime domande e se tu o chi ti sta vicino volesse chiedermi qualcosa, sappi che lo puoi fare sia in privato che scrivendo su questa pagina. Cercherò di rispondere nel più breve tempo possibile. Aggiungo solo un’ultima considerazione. Se pensi di chiedere aiuto agli amici, prima di tutto affida le tue preoccupazioni solo ai veri amici e poi ricordati che gli amici che hai probabilmente sono ragazzi della tua età o giù di lì, che possono ascoltarti, starti vicino e a loro modo sostenerti, ma che possono anche non sapere come aiutarti nel modo migliore perché non hanno le conoscenze e l’esperienza che ha un professionista. Quindi se pensi di avere un problema ed entro un certo tempo da solo o con gli amici non ne vieni fuori prova a pensare ad un’alternativa. Le persone che possono darti una mano ci sono. Io sono qua!

Nell’ambito del Convegno “I giovani e i disagi della sessualità” di qualche mese fa, un medico di base ha elencato le difficoltà che incontra quotidianamente nel tentare di occuparsi della fascia di età adolescenziale e mi sono resa conto che sono circa le stesse difficoltà che incontro io come psicoterapeuta.
I problemi di salute degli adolescenti che possono richiedere l’intervento sia di medici che degli psicoterapeuti sono i più diversi perché si spazia dai problemi d’ansia, alla depressione (in alcuni casi con rischio suicidario), ai disturbi alimentari, all’assunzione e abuso di sostanze come alcol, fumo e droghe, a fenomeni come la dipendenza da internet, la dipendenza dal gioco d’azzardo, il bullismo e molti altri problemi ancora. Insomma i rischi che corre un adolescente sono molti, soprattutto se cade in uno di questi problemi e non riesce ad accedere ad interventi e cure adeguate.
I motivi per cui gli adolescenti accedono con fatica ai servizi a loro dedicati sono diversi:
Come psicoterapeuta, a questo elenco di difficoltà, posso aggiungere anche il problema economico, visto che gli adolescenti dipendono ancora economicamente dai genitori e, ancora una volta, i pregiudizi. Spesso mi capita di essere contattata da genitori e/o insegnanti che rilevano un problema nel proprio figlio o alunno adolescente, il quale però si rifiuta categoricamente di incontrarmi e parlare con me. Spesso si comportano in questo modo perché sono convinti di non avere un problema e il solo fatto di accedere al mio studio significherebbe il contrario. In altri casi, magari concordano sul fatto di avere qualche problema ma sono convinti di potersela cavare da soli o con l’aiuto degli amici.
Potete constatare da soli che gli ostacoli nel trattare gli adolescenti sono tanti e difficili da superare, anche se questa fascia d’età forse è quella che corre maggiori rischi e ha maggior bisogno di aiuto. Per questo motivo, nel mio prossimo post proverò a dare qualche informazione e qualche spunto di riflessione nel tentativo di abbattere qualcuno di quegli ostacoli di cui sopra.

In un precedente articolo ho spiegato a grandi linee in cosa consiste la psicoterapia cognitivo comportamentale (TCC). Oggi vorrei entrare nello specifico dell’applicazione di questa terapia nella fascia d’età dello sviluppo, da 0 a 18 anni, delineando similitudini e differenze.
Vi ricordate quando ho parlato delle difficoltà di riconoscere un problema psicologico in un bambino/adolescente e come fare per superarle? Se dopo attenta osservazione siete giunti alla conclusione che vostro figlio o nipote o allievo sta manifestando i segni di un problema di natura psicologica, i passaggi da mettere in atto sono quelli elencati nell’articolo “Che differenza c’è tra uno psicologo per gli adulti e uno per bambini/adolescenti”. Si tratta quindi i fissare un primo colloquio con uno psicologo/psicoterapeuta, di sottoporre il minore ad una valutazione diagnostica, esattamente come farebbe un medico se si trattasse di un problema organico e di condividere col professionista l’esito della valutazione. Nell’incontro di restituzione lo psicologo/psicoterapeuta non solo formula una diagnosi, cioè spiega se si è in presenza di un disturbo o di un problema transitorio e quale, ma indica anche il possibile percorso da seguire per risolvere il problema. A questo punto quindi si entra nella fase di terapia vera e propria. La TCC per l’età evolutiva presenta similitudini e differenze rispetto alla TCC per gli adulti. Vediamo quali.
Similitudini:
Ma se assunti, obiettivi e tecniche sono gli stessi allora cosa c’è di diverso?
Differenze:
Come sempre se avete domande o riflessioni da fare, postate pure. Nel frattempo auguro a tutti buona giornata.
7 CONSIGLI UTILI PER GLI INSEGNANTI.

Il dott. Russel Barkley, nell’ambito della sua relazione al Convegno Internazionale sull’ADHD, ha voluto dare alcune indicazioni agli insegnanti che si trovano in classe bambini con un Disturbo da Deficit dell’Attenzione e Iperattività, in modo che possano comprendere maggiormente questo disturbo e pianificare in modo adeguato il loro lavoro.
Ecco quindi elencati i 7 principi proposti dal dott. Barkley:
1. Prima di tutto è importante capire che l’ADHD è un disturbo della regolazione delle funzioni esecutive, ossia un disturbo dello sviluppo neuro-biologico e quindi và considerato come una disabilità permanente, non una scelta del bambino di comportarsi male. Se sì comprende questo principio allora ci si potrà attivare per operare tutti gli aggiustamenti necessari per compensare la disabilità del bambino. Da questo primo principio derivano i successivi.
2. L’ADHD interferisce con l’autoconsapevolezza, cioè il bambino non si rende conto di quello che sta facendo. Quando perde il controllo è quindi importante che sia l’insegnante a fermarlo e aiutarlo a diventare consapevole più di sé chiedendogli di descrivere cosa sta facendo e sentendo. Può essere utile creare dei report con elencati diversi comportamenti che il bambino può compilare alla fine di ogni lezione o giornata per valutare come si è comportato. Quando invece è riuscito ad eseguire un compito o una richiesta è molto utile filmarlo per poi mostrargli come si è comportato e rinforzare positivamente il suo comportamento in modo che lo possa ripetere.
3. Il bambino con ADHD ha difficoltà ad inibire certi comportamenti, può quindi essere utile concordare con lui un suggerimento o un gesto che gli faccia capire di fermarsi e guardarsi intorno molto attentamente. Un esempio in tal senso è la tecnica della tartaruga. Quando l’insegnante dice la parola tartaruga il bambino deve comportarsi come una tartaruga, quindi ritrarre le zampe dentro il guscio, guardarsi bene intorno, osservando lentamente e attentamente cosa succede nell’ambiente e pensare bene cosa deve fare.
4. L’ADHD è una disfunzione della memoria di lavoro perciò dobbiamo aiutare il bambino a ricordare le cose che gli abbiamo chiesto utilizzando ad esempio liste, post-it, calendari o segnali convenzionali. Non sembra essere molto utile la tecnologia, come gli smartphone, perché il bambino o il ragazzo con adhd tendono a dimenticarli, a dimenticarsi di ricaricarli, a dimenticarsi di impostarli. Sono molto più utili gli strumenti materiali, oggetti fisici come quelli sopra elencati.
5. Chi soffre di ADHD ha molte difficoltà nell’automotivazione, per questo motivo spesso si annoia o non si interessa ad un compito. E’ necessario quindi rendere la motivazione fisica e reale, trovare un premio tangibile e interessante che motivi il bambino ad eseguire le nostre istruzioni.
6. Il bambino con ADHD non sa regolare le sue emozioni che possono quindi essere molto forti e provocare reazioni impulsive e inappropriate. Può essere utile in questo caso trovare uno spazio tranquillo dove il bambino possa calmarsi e concordare delle autoistruzioni che possa ripetere a sé stesso per calmarsi. Anche in questo caso fare un video al bambino quando riesce a calmarsi e mostrarglielo sottolineando la sua bravura, può essere un rinforzo positivo perché ripeta quello stesso comportamento anche in altre occasioni.
7. Chi soffre di ADHD non sa pianificare e risolvere i problemi perché non sa manipolare le informazioni. Il problem solving di solito si basa su un gioco mentale ma se riusciamo a trasformare questo gioco in qualcosa di fisico e concreto, per esempio usando degli oggetti come delle biglie colorate, allora ci può riuscire.
Spero che queste poche indicazioni possano essere utili a chi a scuola si occupa di bambini o ragazzi con ADHD. Lo scopo principale è far conoscere bene questo disturbo perché se lo si comprende per quello che è allora si può aprire la strada alle soluzioni giuste.
A cura del dott. Russell A. Barkley, Ph.D. intervenuto al Convegno Internazionale “ADHD e Disturbi Dirompenti del Comportamento”.
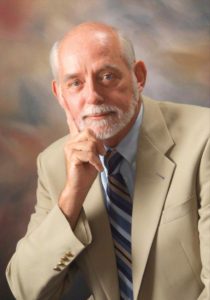
Il Dott. Brakley è un’autorità riconosciuta nel campo del Disturbo da Deficit dell’Attenzione e Iperattività nei banbini e negli adulti. Ha dedicato la sua carriera a diffondere informazioni scientifiche sull’ADHD. E’ un professore di psichiatria del Centro per il trattamento dei bambini della Virginia e del Centro medico universitario dell Virginia.